Massimo Silverio è uno di quegli artisti che sembrano arrivare da un altrove sospeso, da un luogo che non si trova sulle mappe ma che si riconosce subito nel suono. Nato in Carnia, nel Friuli montano, ha scelto di cantare nella lingua del suo territorio — il carnico — non come gesto di folklore, ma come atto poetico e politico insieme. È una lingua che vibra, ruvida e ancestrale, fatta di consonanti che si spezzano e di vocali che si allungano come echi di vento tra le montagne. In questa lingua Silverio costruisce da anni un universo musicale che unisce radici e sperimentazione, voce e spazio, natura e rumore. Il suo primo album, Hrudja (tra i nostri 30 migliori dischi del 2023), era già un piccolo manifesto: un disco che respirava la terra, il legno, la memoria. Lì Silverio sembrava ancora legato a una forma di canzone più riconoscibile, anche se già tesa verso qualcosa di più profondo. Con Surtùm, invece, fa un passo oltre: scende più in basso, come suggerisce il titolo stesso — “Surtùm” in carnico significa “palude” — un luogo di materia densa, dove l’acqua non scorre ma trattiene, dove le cose si depositano e mutano lentamente.
Prodotto da Manuel Volpe con la collaborazione di Nicolas Remondino e altri musicisti che arricchiscono gli arrangiamenti (tra cui Mirko Cisillino, Flavia Massimo, Benedetta Fabbri e Martin Mayers), Surtùm si presenta come un’opera compatta, coerente, scura. Laddove Hrudja alternava momenti di apertura melodica a passaggi più sperimentali, qui tutto sembra filtrato da una luce più tenue, come se ogni suono nascesse in penombra. Gli archi, i fiati, l’elettronica e la voce si intrecciano in un unico respiro: più che un disco di canzoni, Surtùm è un organismo vivo, un ambiente da abitare.

Fin dal brano d’apertura, Sorgjâl, si percepisce la volontà di spingersi oltre la forma canzone. Dieci minuti di rito sonoro, un crescendo lento e inesorabile, dove la voce si fa preghiera, incantamento. È un inizio che chiede tempo e attenzione: l’ascoltatore deve lasciare andare la fretta, accettare di farsi trascinare. Poi arriva Avenâl, più intima, quasi una sorgente che nasce sottovoce. Zoja, uno dei singoli, riporta un briciolo di riconoscibilità melodica, ma resta immersa in un’atmosfera sospesa: un motivo circolare che si avvolge su sé stesso, come una ghirlanda funebre, simbolo di vita e morte intrecciate.
Nel cuore del disco, Vàre e Prin portano la tensione nel suo punto massimo. Sono brani che sembrano costruiti più sul respiro che sul ritmo, su immagini visive — carcasse, brina, sole che crolla — che evocano la fragilità e la bellezza della natura. Qui la voce di Silverio si fa strumento, corpo che vibra, quasi scompare dentro il paesaggio sonoro. Grim riporta un momento di tregua, come un ritorno al grembo, alla madre, al calore di un’origine che non consola ma accoglie. Infine Ghirbe chiude il disco con un senso di apertura: non una fine, ma una sospensione, un respiro che rimane nell’aria.
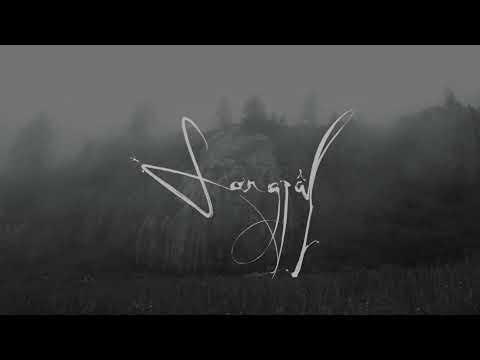
La differenza più evidente rispetto a Hrudja è nella struttura e nel tono. Dove il primo album aveva ancora tracce riconducibili a un certo folk contemporaneo, Surtùm si libera quasi completamente di ogni convenzione: è un lavoro più vicino all’ambient, al post-rock atmosferico, a quella linea spirituale che unisce artisti come Anna von Hausswolff, Sigur Rós o Ben Frost, ma con una radice terrena e carnale tutta italiana che strizza l'occhio a DIE di Iosonouncane. È un disco che nasce dalla terra e dalla lingua, eppure guarda verso l’alto, verso qualcosa di arcaico e universale.
Non è un ascolto semplice, e non vuole esserlo. Silverio non offre canzoni da canticchiare né ritornelli da memorizzare: invita piuttosto all’abbandono, a un’esperienza lenta, quasi meditativa. La sua voce, filtrata dal carnico, non è un ostacolo ma un ponte: anche chi non comprende le parole può sentirne la verità, la materia emotiva che le sostiene. C’è qualcosa di profondamente autentico nel modo in cui Silverio usa il suono — come se cercasse di restituire non solo la lingua di un popolo, ma il battito stesso di una montagna, il rumore dell’acqua che scorre sotto la superficie. Surtùm è un disco che richiede spazio, silenzio e predisposizione. È musica che non vuole distrarre, ma trasformare l’ascoltatore, portarlo in un luogo dove il tempo si dilata e ogni suono acquista un peso diverso. È, in fondo, un atto di coraggio artistico: in un panorama musicale spesso ossessionato dalla velocità e dall’immediatezza, l'artista sceglie la lentezza, la profondità, il mistero.

Rispetto al suo esordio, questo nuovo lavoro è un’immersione più radicale: se Hrudja raccontava la ferita che si rimargina, Surtùm scava nella palude dove quella ferita è nata, per capire cosa la genera e come può ancora pulsare. È un disco di fango e di luce, di ombre che respirano, di lingue che non si estinguono ma si trasformano. E alla fine, ciò che resta non è solo la bellezza di un suono, ma la sensazione di aver attraversato qualcosa — un paesaggio, una memoria, una soglia. In un tempo che consuma tutto in fretta, questo disco ci ricorda che certe cose, per esistere davvero, devono restare lente, dense e difficili.
